La trama della resistenza
“Dalla piazza Alameda mi trovo catapultato in un paesino chiamato Tierra Blanca, nella regione di Oaxaca. Sono circondato da donne, uomini e bambini. Condividono la lingua, la terra e un sapere tramandato da migliaia di anni, da tempi antecedenti alle prime mappe europee del Nuovo Mondo. Nelle pieghe della loro pelle vive la terra stessa che coltivano, dalla quale traggono da vivere e grazie alla quale si identificano nella popolazione indigena Trichi. Dal 26 dicembre 2020, però, la loro identità è stata calpestata con forza; per essere più chiari, è stata fisicamente aggredita da un gruppo di uomini paramilitari accecati dalla violenza.”
Bene, questo è un estratto del seguente diario, scritto nel 2022 in Messico. Intanto, se state leggendo (o ascoltando) questo articolo, vi ringrazio per il tempo e l’attenzione dedicata. Ho voluto dare forma audio ai miei testi ed esperienze per renderli più accessibili. Vi chiedo anche di interpretare lo scritto in onore delle terre e delle persone incontrate, allargando la prospettiva oltre la mia esperienza personale.
Ora, si parte!
Piazza adiacente al Parco Alameda, ingresso al Museo delle Belle Arti, Città del Messico, Messico.
Ascoltando la vita attorno a me, sento una vibrazione stimolante e affascinante, uno di quei motivi che può suscitare sia disagio che piacere. È una sensazione mutevole, che dipende sia dal mondo esterno sia da come mi pongo di fronte ad esso, quel frutto alchemico che non sempre riconosco ma che mi porta ad amare o ad evitare un luogo. Le mie parole si nascondono all’interno di questo infuso, oltre il sottofondo delle macchine, in sintonia con gli orchestrali venditori ambulanti, con i clacson e i musicisti di strada. Il tutto crea una melodia unica e inimitabile, un’impronta digitale che ogni città coltiva con orgoglio e dedizione. Una forma di espressione della propria cultura.
Il sole si è ormai alzato, attenuando così quella tipica frescura delle mattine di febbraio a Città del Messico. Sebbene ora mi trovi all’incirca alla stessa latitudine di Santo Domingo e Cuba, una distanza di oltre 2000 metri separa i miei piedi dal livello del mare, un’altitudine tale da rendere le mattine fresche e i mezzogiorni temperati. Un clima perfetto per vivere appieno la città.
La strada è costellata di carretti colorati. I mercanti chiamano a sé i passanti. I profumi del cibo inondano le narici, solleticano le pance e, come magneti sociali, attraggono turisti e locali. Tutti attendono in file (dis)ordinate, pronti a fermare il tempo e a dare spazio alle costellazioni sensoriali di tali prelibatezze. In mezzo a questo concerto di suoni, profumi e colori, condivido lo spazio e le emozioni con Valerie, sorpresa e innamorata quanto me di questo vivere così diverso dal nostro.
Alle mie spalle vedo il Museo delle Belle Arti, un monumento artistico dalle facciate in pieno stile Art Nouveau. Ancora oggi, come una cicatrice in vista, ricorda ai cittadini il periodo del Porfiriato: un periodo storico imposto dal dittatore Porfirio Diaz, caratterizzato dalla tangibile influenza francese nella moda, nell’arte e nell’architettura. Un periodo di cambiamento socio-politico, che represse fortemente le popolazioni indigene e le loro espressioni culturali. Correvano gli ultimi anni dell’800 e i primi del ‘900, ma ancora oggi gli effetti sono pienamente palpabili.
Alla mia sinistra si staglia l’imponenza della Torre Latinoamericana, una costruzione alta 182 metri, riconosciuta per la sua modernità e robustezza. Così solida e forte da essere ricordata per la sua resistenza ai due storici terremoti del ‘57 e del ‘85, concedendole il vanto di essere considerata tra gli edifici più sicuri al mondo.
Un’opera di resilienza
Ai piedi di queste due sfarzose opere d’arte, invece, risuona un’altra opera di estrema resistenza, o, forse meglio, di resilienza. Un complesso di bivacchi rudimentali e tende è radicato nel pieno centro della piazza adiacente al Parco Alameda. Il tutto è circondato da transenne con affissi dei manifesti e, anche a prima vista, appare evidente la stabilità del campo. Delle cucine sono state arrangiate sotto a dei tendoni, ci sono bambini che giocano, donne che tessono e persone che lavorano. Mi ricorda una piccola città arroccata all’interno della capitale, fisicamente divisa ma al contempo inglobata dall’imponenza della metropoli.
Al pari di un fiume che scorre agli estremi di un isolotto, levigandone la roccia e smussando gli spigoli più sporgenti, le persone passano ai margini di questo prezioso fiore di resistenza. Un germoglio nato dalle più profonde radici della rivendicazione dei diritti umani, dal rifiuto della violenza in quanto mezzo di potere e dall’uso della propria voce e del proprio corpo, come ancora di salvezza dalle distratte correnti della vita quotidiana. I ritmi frenetici, troppo veloci per permettere all’attenzione di fissarsi a lungo e al nostro cervello di emozionarsi dinanzi a tale ingiustizia, creano un muro invisibile che ci divide da loro, una distanza presente nelle nostre teste, una malattia che anestetizza i cuori e deumanizza le persone. Alcuni cittadini di questo angolo abitato provano a richiamare a sé i passanti, sperando di fare breccia in quel concerto di effimere priorità, ma la calca ha fretta e schiva abilmente il confronto, seguendo indisturbata le sue faccende quotidiane.
Il mio sguardo si ferma su una donna anziana, seduta a terra, circondata da alcuni peluche. Con la stessa fermezza della vicina Torre Latinoamericana, prosegue il suo lavoro di tessitura e di resistenza. I capelli, dipinti di un grigio eterogeneo, creano un caratteristico gioco di chiaro e scuro, tanto espressivo quanto le profonde solcature tracciate sul viso. La sua pelle, come una voce narrante, racconta parte della sua vita e della sua cultura, in cui l’invecchiare non è nascosto da artifici superficiali. Indossa una tunica tipica, dalla trama fitta e dai colori accesi. La base rossa è intervallata da spruzzate geometriche di forme e tinture diverse. Le ginocchia sono flesse, creando così, con le proprie gambe, una seduta in cui posizionare il proprio corpo composto. Sotto le proprie tibie un pezzo di cartone la protegge dal duro suolo cementato, una posizione scomoda da mantenere a lungo. Le sue mani giocano con veloce maestria tra i fili di un telaio a tensione, sistemato tra il proprio corpo e una staccionata. Con un lento movimento, schiude tale incomoda posizione, distende gli arti inferiori davanti a sé e poi li incrocia in segno di riposo. Io e Valerie ci avviciniamo, incrociamo il suo sguardo e scambiamo un primo timido saluto. Mosse le prime parole, l’anziana signora si volta per guardarci con dolcezza, indicandoci un’altra donna poco distante. Quest’ultima, intuendo le nostre intenzioni, si avvicina e ci spiega che la donna non parla spagnolo, ma solo la sua lingua nativa, un idioma secolare che la conquista spagnola non è ancora riuscita ad eradicare. E così, con una travolgente energia, l’iniziale cenno si trasforma in una storia che ha dell’incredibile. Una di quelle realtà a cui siamo abituati a sentire e vedere attraverso gli schermi. Grazie alla tecnologia siamo sommersi di informazioni, che, purtroppo, a volte si trasformano in storie ovattate, con sensazioni anestetizzate, come se i personaggi fossero frutto dell’immaginazione o di un mondo parallelo. Questo, però, non è un film: è la realtà. Persone in carne ed ossa hanno vissuto queste esperienze, come molte altre lo stanno facendo oggi stesso, e lo faranno domani. Ti chiedo ora di fare uno sforzo di attenzione. Cerca di immedesimarti quanto più possibile nelle prossime righe, e immagina solo per un momento di essere dentro questo racconto, che di finzione ha solo gli alibi.
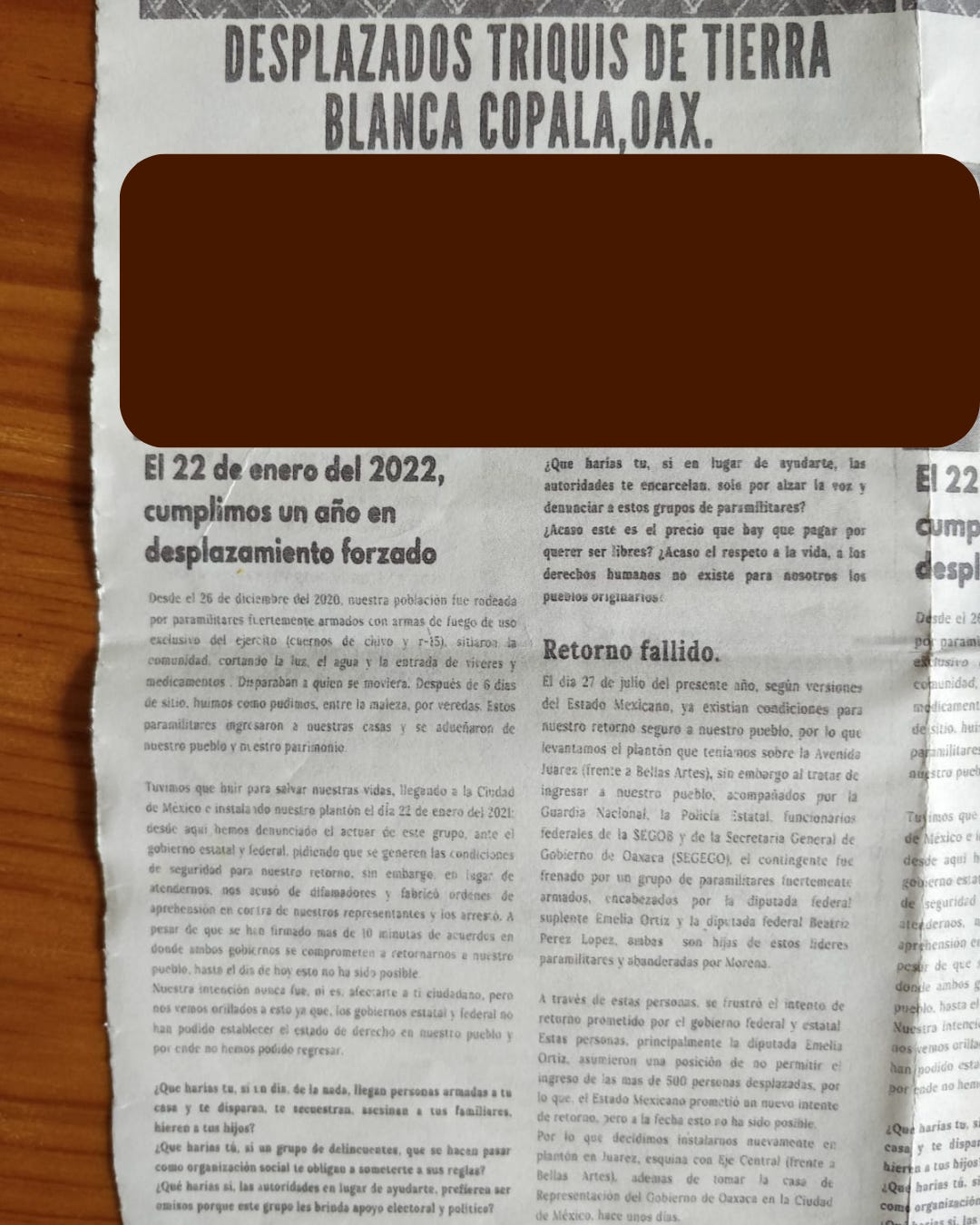
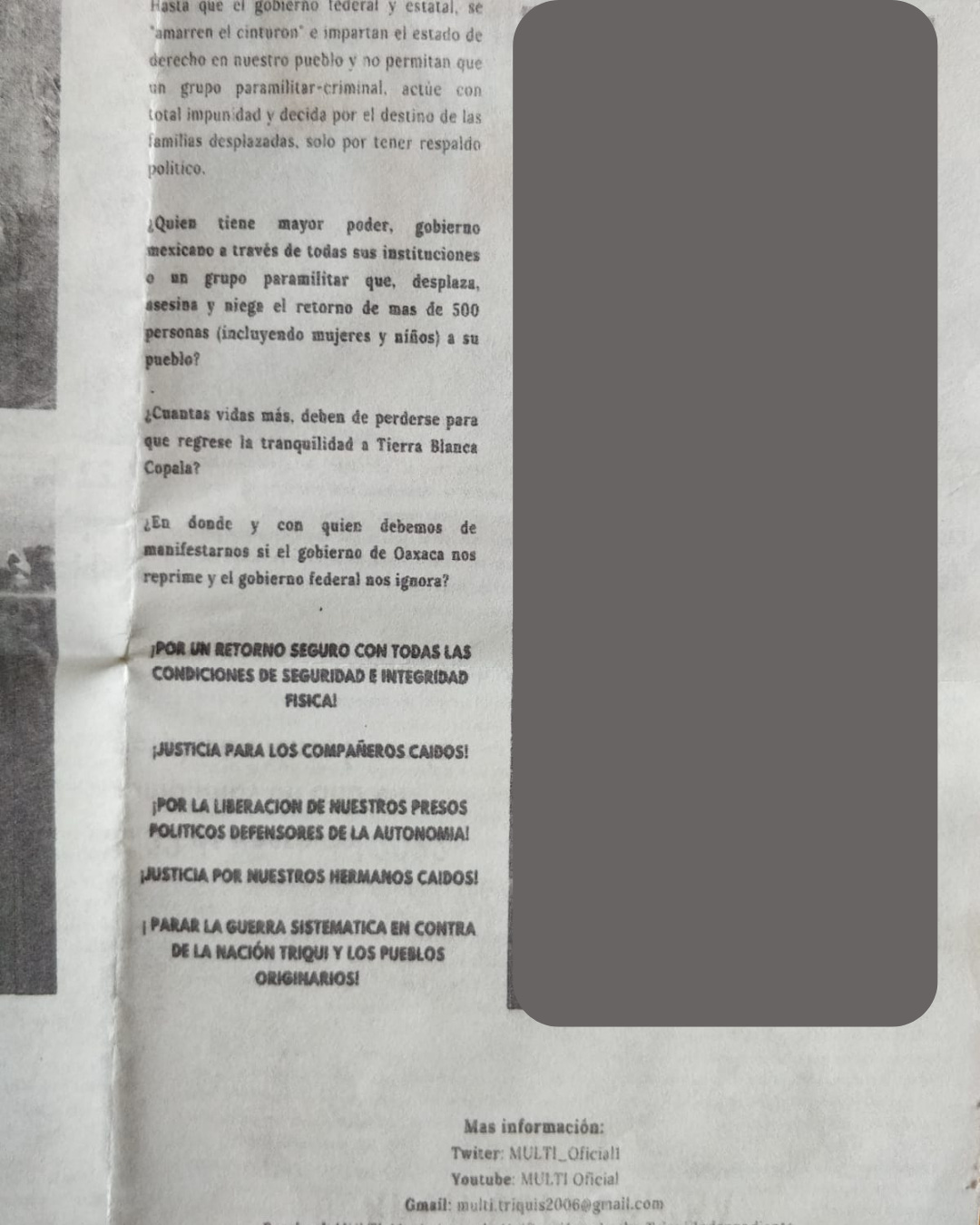
Dalla piazza Alameda mi trovo catapultato in un paesino chiamato Tierra Blanca, nella regione di Oaxaca. Sono circondato da donne, uomini e bambini. Condividono la lingua, la terra e un sapere tramandato da migliaia di anni, da tempi antecedenti alle prime mappe europee del Nuovo Mondo. Nelle pieghe della loro pelle vive la terra stessa che coltivano, dalla quale traggono da vivere e grazie alla quale si identificano nella popolazione indigena Trichi (Triquis in spagnolo). Le loro terre corrispondono in parte all’area geografica che in Occidente chiamiamo Oaxaca, in particolare nelle municipalità di Juxtlahuaca, Putla e Tlaxiaco. Queste regioni fanno parte di una terra e di una cultura che originariamente venivano definite Mixteca, letteralmente il “luogo del popolo delle nuvole”, e non è difficile comprenderne il motivo, considerato che la comunità Trichi vive in paesi con elevazioni comprese tra i 1500 e i 3000 metri di altitudine.
Dal 26 dicembre 2020, però, la loro identità è stata calpestata con forza; per essere più chiari, è stata fisicamente aggredita da un gruppo di uomini paramilitari accecati dalla violenza. Le loro terre sono state ingiustamente espropriate, la loro identità è stata sgretolata e le loro vite sono state costrette a morire o a migrare. Il rumore degli spari, la morte dei propri cari, l’odore del sangue e il terrore si uniscono a una cornice di un’immagine terrificante. Parte della propria identità lasciata alle spalle. Le piccole borse stracolme di speranza, dell’amore per la vita, della lotta contro le ingiustizie, trasportate fino a Città del Messico, nella piazza adiacente al Parco Alameda, di fronte al Museo di Belle Arti, di fronte agli occhi di tutti. Dal 22 gennaio 2021 resistono, combattono per trasformare la resistenza in resilienza, in una nuova fioritura da terreni aridi alla compassione. Vivono in trincea di fronte all’emblema del Porfiriato, affacciati al banchetto degli agiati, di fronte ad un loculario costellato di popolazioni e culture di cui la storia, la “nostra storia”, si è dimenticata.

Mi giro e rientro dall’anziana signora. Le chiedo con lo sguardo se posso ammirare il suo lavoro e fotografarla mentre opera. La sua forza mi coinvolge, ammiro la sua resilienza e rinnego la mia inflessibilità nell’affrontare gli ostacoli che incontro. Probabilmente non lo sa, ma il suo laborioso tessere, salvaguardato da tali difficoltà, rimarrà impresso nella mia mente come un amuleto a cui fare riferimento nei momenti di oppressione.
Resistenza
In questi mesi vedo una rivoluzione in Italia; sto osservando ciò che non credevo possibile, ciò che da anni sognavo e che avevo nascosto nei cassetti dei desideri irrealizzabili. Una nuova fiamma di speranza si accende nel mio cuore. Vedere la mobilitazione di massa contro ingiustizie che non sono presenti in casa nostra mi ha riacceso l’ottimismo per un mondo migliore. Possiamo ancora unirci per ciò che è giusto, e non in base alle fazioni politiche. Che questa energia, questa unione, questa compassione per il prossimo possano essere il primo passo di un movimento ancora più ampio. Perché oggi stiamo affrontando una delle rivoluzioni che caratterizzeranno il corso della storia della Terra stessa. Come dicono Joanna Macy e Chris Johnstone nel loro libro “Active Hope”, un capolavoro che critica la crescita economica in un mondo di risorse limitate, stiamo attraversando una transizione epocale da una società della crescita (economica appunto), ad una società a supporto della vita. Il significato e il ruolo che attribuiamo alla nostra speranza saranno l’ago della bilancia nel determinare i nostri comportamenti prosociali e proambientali e, di conseguenza, il nostro futuro.







